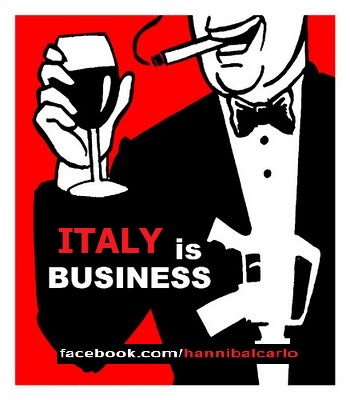Gandhi e la «marcia
del sale»
(da La
verità di Gandhi. Sulle
origini della nonviolenza
militante, trad. di
R. Steiner e R. Petrillo)
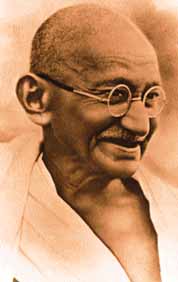 Nel
marzo 1930 il Mahatma Gandhi
iniziò una nuova campagna. Si
accingeva ad abbandonare
Ahmedabad una volta e per
sempre, facendo voto di non
ritornarvi mai più finché
l’India non avesse acquistato la
completa indipendenza. La
partenza fu una delle più
drammatiche e delle più ispirate
della storia. Per la vigilia del
lungo viaggio di duecento miglia
fino alle sponde del Mar
Arabico, dove il Mahatma avrebbe
raccolto alcuni granelli di sale
dell’oceano che prende nome
dall’India. La legge sul sale
sarebbe stata infatti il cardine
della sua campagna di
disobbedienza civile. Si
trattava di un’imposta che agli
Inglesi fruttava non più di
venticinque milioni di sterline
sugli ottocento milioni di
gettito tributario complessivo
in India, ma quei venticinque
milioni venivano letteralmente
attinti al sudore dei più poveri
e a una derrata abbondantemente
disponibile lungo le varie
migliaia di miglia di sviluppo
costiero indiano. Teatro del
gran gesto di emancipazione – e
delle più sanguinose
rappresaglie – sarebbe stata
Dandi, cittadina nei pressi di
Jalalpur e prospiciente
l’imboccatura del golfo di
Cambay. La sera dell’11 marzo
Gandhi aveva tenuta la sua
ultima adunanza di preghiera. Di
fronte a migliaia di persone
aveva annunciato:
Nel
marzo 1930 il Mahatma Gandhi
iniziò una nuova campagna. Si
accingeva ad abbandonare
Ahmedabad una volta e per
sempre, facendo voto di non
ritornarvi mai più finché
l’India non avesse acquistato la
completa indipendenza. La
partenza fu una delle più
drammatiche e delle più ispirate
della storia. Per la vigilia del
lungo viaggio di duecento miglia
fino alle sponde del Mar
Arabico, dove il Mahatma avrebbe
raccolto alcuni granelli di sale
dell’oceano che prende nome
dall’India. La legge sul sale
sarebbe stata infatti il cardine
della sua campagna di
disobbedienza civile. Si
trattava di un’imposta che agli
Inglesi fruttava non più di
venticinque milioni di sterline
sugli ottocento milioni di
gettito tributario complessivo
in India, ma quei venticinque
milioni venivano letteralmente
attinti al sudore dei più poveri
e a una derrata abbondantemente
disponibile lungo le varie
migliaia di miglia di sviluppo
costiero indiano. Teatro del
gran gesto di emancipazione – e
delle più sanguinose
rappresaglie – sarebbe stata
Dandi, cittadina nei pressi di
Jalalpur e prospiciente
l’imboccatura del golfo di
Cambay. La sera dell’11 marzo
Gandhi aveva tenuta la sua
ultima adunanza di preghiera. Di
fronte a migliaia di persone
aveva annunciato:«Con ogni probabilità questo sarà il mio ultimo discorso rivolto a voi. Anche se domani mattina le autorità mi consentiranno di marciare, queste potrebbero essere le ultime parole della mia esistenza qui. Già vi ho detto ieri quel che avevo da dirvi. Oggi mi limiterò a comunicarvi quel che dovrete fare dopo che i miei compagni e io saremo stati arrestati. Da quel che ho visto e udito in questi ultimi giorni sono incline a ritenere che il fiume dei resistenti civili scorrerà ininterrotto. Ma non vi sia neppure il minimo accenno a una violazione della pace, anche dopo che saremo stati tutti arrestati. Abbiamo deciso di utilizzare tutte le nostre risorse nel perseguimento di una lotta esclusivamente non violenta: non lasciamoci trascinare dall’ira a metterci dalla parte del torto. Questa è la mia speranza e il mio auspicio. Desidero che queste mie parole giungano in ogni buco e in ogni angolo della nostra terra».
Gandhi si mise in marcia sul far del giorno, uscendo dai cancelli dell’ashram e avviandosi sulla strada di Dandi alla testa di settantotto tra uomini e donne. A quell’epoca il Mahatma aveva già oltre sessant’anni, ma dodici miglia al giorno per ventiquattro giorni erano «un gioco da ragazzi». Anzi, come attestano i documenti cinematografici girati in quell’occasione, non mancava l’allegria in questo pellegrinaggio che si snodava tra villaggi parati a festa e lungo strade di campagna che i contadini avevano irrorato d’acqua per arrestare il polverone e pavimentato di foglie per attutire il disagio delle pietre e delle cunette. Alla fine il Mahatma raccolse un pugno di sale. Non vi furono in nessuna parte dell’India violenze degne di nota.
Tuttavia l’assenza stessa di violenze irritò fino alla crudeltà la polizia. C’è il resoconto di un inviato inglese, il giornalista Webb Miller: sotto la guida di Sarojini Naidu e di Manilal Gandhi duemilacinquecento volontari mossero «all’assalto» delle saline di Dharasana, non lungi da Dandi.
“Nel più assoluto silenzio gli uomini di Gandhi si portarono avanti e si arrestarono a un centinaio di metri dalla palizzata. Una colonna scelta si staccò dalla turba, attraversò i fossati a guado e si accostò alla recinzione di filo spinato... Improvvisamente risuonò un comando e ventine di agenti indigeni si precipitarono sui manifestanti e lasciarono piovere un torrente di colpi sulle loro teste con gli sfollagente dall’anima d’acciaio. Non uno solo dei manifestanti alzò un braccio per ripararsi dai colpi. Cadevano come birilli. Da dove mi trovavo, udivo i tonfi stomacanti delle mazze sui crani indifesi. La folla dei manifestanti che era rimasta ferma cominciò a mugolare e ad aspirare rumorosamente l’aria a ogni colpo, manifestando così la propria dolorosa solidarietà. I colpiti cadevano privi di sensi sul terreno, o si torcevano tra i corpi caduti, chi con la testa fracassata chi con una spalla fratturata... I superstiti, senza rompere le righe, continuavano a marciare silenziosi e ostinati, finché non cadevano a loro volta sotto i colpi. Marciavano impassibili, a testa alta, senza neppure l’incitamento della musica o di urla guerriere, senza alcuna probabilità di sfuggire a ferite gravi o alla morte. I gendarmi si allargarono a ventaglio e, metodicamente, meccanicamente, cominciarono a picchiare sulla seconda colonna. Non vi fu lotta, non vi fu battaglia: i manifestanti continuavano semplicemente ad avanzare finché non si abbattevano al suolo...”
Per ore e ore i barellieri sgomberarono una marea di corpi inerti e sanguinanti.
Che cosa avevano ottenuto i Satyagrahi? Non occuparono le saline, né la legge sul sale venne ufficialmente abolita nella sua interezza. Ma non era questo il punto, come l’opinione pubblica mondiale non doveva tardare a comprendere. Il Satyagraha del sale aveva dimostrato al mondo l’utilità quasi perfetta di un nuovo strumento di militanza pacifica. Basterà aggiungere qui che, dopo un altro soggiorno in prigione, Gandhi incontrò il viceré a un ormai famoso tea party . Dopo qualche compromesso da entrambe le parti, Gandhi era stato infatti invitato a una conversazione con il rappresentante imperiale. Churchill alzò sprezzantemente le spalle alla notizia del «sedizioso fachiro che mezzo nudo s’avventura sulla scalinata del palazzo vicereale, per negoziare con il vicario del Re e Imperatore». Invece il viceré, Lord Irwin, ha descritto l’incontro come «il più drammatico colloquio diretto tra un viceré e un capo indiano». Quando gli porsero la tazza di tè, Gandhi estrasse dalle pieghe della sua clamide un sacchettino di carta e ne versò nel tè il contenuto: un pizzico di sale, naturalmente esente da tasse, osservando sorridente che sarebbe servito a «ricordarsi del famoso tea party di Boston». L’anno seguente si sarebbe recato in Inghilterra per la Conferenza della tavola rotonda, unico rappresentante del Congresso e capo mondiale ormai popolarissimo persino presso le masse inglesi.
Nel maggio del 1930 Tagore scrisse trionfante al «Manchester Guardian» che ormai l’Europa aveva perso in Asia tutto il suo prestigio morale. La debole Asia, egli affermava, lodando il Mahatma, «può ora permettersi di guardare dall’alto in basso quell’Europa che prima doveva guardare dal basso in alto».
Webmaster: Carlo Anibaldi